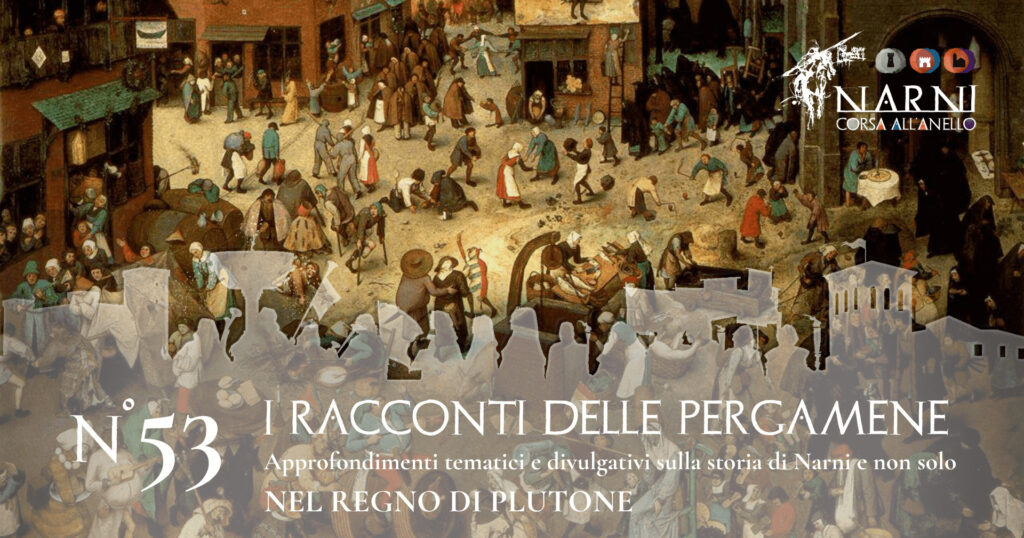NEL REGNO DI PLUTONE
Il Carnevale nel Medioevo
Cosa si nasconde dietro questo rito antichissimo?
Carnevale, tempo di maschere. Ma cosa si nasconde dietro questo rito antichissimo? Se è evidente che la maschera permette di assumere una personalità diversa, è anche vero che seppur inconsciamente, evoca un aspetto molto più profondo, legato al dualismo morte-Plutone.
Plutone, dio degli inferi, amava le maschere, il mistero e le illusioni della notte, così come amava la morte, ultima illusione dell’esistenza. L’atto di mascherarsi non è solo una semplice trasformazione esteriore, ma anche un’operazione misterica che affonda le sue radici nelle antiche cerimonie sacre riservate agli iniziati, a coloro che avevano la capacità e il permesso di scendere nel regno di Plutone, accedendo così al mistero della vita e della morte. Trasformando l’apparenza di chi la indossava, la maschera aveva la funzione mistica di far uscire l’uomo dal sé stesso esteriore per farlo entrare nel profondo di sé stesso.
Dai Saturnali romani alle molte feste medievali di tipo carnevalesco
Per l’uomo medievale, la festa era il luogo nel quale si saldavano e in qualche modo si pacificavano le due opposte concezioni del tempo: quella lineare della vita umana, che ha un inizio e una fine, e quella ciclica della natura che non nasce e non muore mai, perché rinasce sempre uguale a sé stessa. Questo doppio momento di tempo poteva essere annullato solo nella festa, tornando al caos primordiale nel quale le divisioni sociali non esistevano ancora. Ed è proprio questo il senso delle inversioni di ruolo che si producevano in alcune feste: dai Saturnali romani alle molte feste medievali di tipo carnevalesco (anche se nacquero prima del Carnevale strettamente inteso). Erano le feste dei folli, nelle quali una sola volta durante l’anno, le gerarchie sociali venivano completamente rovesciate: si eleggevano re e regine della festa, vescovi bambini o folli. Tutto questo lo raccontano le fonti ecclesiastiche, attraversi i tanti divieti che comparvero sin dall’inizio del Medioevo, nei quali si condannavano questi riti: “travestimenti di uomini in animali o in donne, balli, canti, sfrenatezze sessuali e alimentari e che si consumano anche nelle chiese” (Sermo Pseudo-August., Cesario di Arles). Va detto infatti che a queste feste non partecipava solo il popolo, ma anche una parte del clero perché, soprattutto nei primi tempi, la loro organizzazione nasceva proprio all’interno della Schola. Quanto al dispregio delle “sfrenatezze alimentari”, non a caso anche gli Statuti narnesi del 1371 vietarono di offrire merende o qualsiasi tipo di cibo cotto o crudo da 15 giorni prima della fine del carnevale (Statuti, Libro III, Capitolo LXXXVIII).
I divieti ecclesiastici
I divieti ecclesiastici, persistenti e reiterati quasi sempre con le stesse argomentazioni, testimoniano da un lato l’impotenza della Chiesa di fronte alle tradizioni radicate, ma anche una sorta di accettazione delle stesse: i riti infatti erano circoscritti ad un periodo di tempo determinato e in un certo senso agivano da “tranquillante sociale”. Una sola volta l’anno, anche le classi subalterne potevano sperimentare modalità di vita completamente diverse dalla dura realtà di tutti i giorni. I Mondi alla rovescia e i Paesi di cuccagna dell’immaginario medievale, contrapponevano la realtà terrena a quella infinita ed eterna del mondo ultraterreno, uno dei temi centrali del cattolicesimo.
Molte di queste feste erano prima di tutto cerimonie propiziatorie per la fecondità della terra e ancora oggi conservano una sacralità pagana che neppure la loro cristianizzazione è mai riuscita a cancellare. Anche nei riti carnevaleschi, così come in tutti i riti propiziatori, c’era una sospensione tra il mondo terreno e l’aldilà nel quale i vivi e i morti potevano finalmente incontrarsi e comunicare. Gli uomini volevano salvaguardare i semi che avevano piantato sottoterra e per farlo dovevano ingraziarsi le forze che comandavano nel sottosuolo: gli dei degli inferi e i morti. Rovesciando l’ordine quotidiano, coloro che abitavano nell’aldilà, potevano tornare sulla terra e prenderne il potere una volta l’anno. Per questo motivo le brigate degli Arlecchini (già nella seconda metà del 1200, in Francia, Hellerquin/Hellequin era divenuto un diavolo comico) e le schiere dei diavoli potevano percorrere le strade indisturbati. Se nella quotidianità erano raffigurazioni spaventose e veri e propri deterrenti contro il peccato, durante la festa i diavoli finivano per essere esorcizzati: si poteva ridere di loro rappresentandone il lato grottesco.
Il Re Carnevale
Durante i riti carnevaleschi, l’incoronazione di un re del Carnevale era una vera e propria parodia che rappresentava l’essenza della visione di un Mondo alla rovescia, perché ad essere incoronato era generalmente un uomo qualunque, non di rado “lo scemo del villaggio”, un re per burla da contrapporre a quello vero.
Alla base di questa elezione, alla successiva detronizzazione ed uccisione simbolica di re Carnevale (peraltro accompagnata dalla stesura di un testamento e da processioni e pianti), c’era il significato stesso del rito: rovesciare la realtà, seppellire l’anno vecchio per andare verso il rinnovamento. Caratteristico in questo senso era anche l’utilizzo di oggetti indossati alla rovescia, come ad esempio gonne al posto dei mantelli, vasi indossati come copricapi e semplici utensili domestici esibiti come armi. Secondo alcuni studiosi il personaggio simbolico di re Carnevale nacque storicamente nella liturgia cristiana in funzione antitetica alla Quaresima e fu concepito come personificazione del tempo, di una stagione. Il Carnevale era infatti una sorta di festa di Capodanno e in un’esistenza misurata solo dalla vita nei campi, celebrava la morte dell’anno vecchio (la fine dell’inverno) e l’inizio del nuovo: la primavera e la rinascita vegetale. La sua funzione era quella d’instaurare un rituale rapporto con il regno dei morti, come testimonia la tradizione del testamento, con il quale, in forma pubblica, si denunziavano le disgrazie e i mali che si erano consumati nell’anno appena concluso. Ma il clamore delle feste carnevalesche era cosciente dei propri limiti. Si rideva con quel tanto di amaro in bocca dovuto alla coscienza di sapere che di lì a poco sarebbe iniziato il periodo quaresimale.
L’eterno contrasto tra Carnevale e Quaresima
L’eterno contrasto tra Carnevale e Quaresima era ben rappresentato nelle feste medievali: in alcuni casi infatti, alla processione che accompagnava al “rogo” re Carnevale, presenziava una donna che interpretava appunto “madonna Quaresima”, moglie, antagonista ed alter ego femminile di Carnevale. Il suo pianto per la detronizzazione e la condanna a morte del marito, erano puramente simbolici: ogni anno Quaresima, succedendo per motivi temporali al periodo carnevalesco, usciva vincitrice dallo scontro. Con il suo avvento si ripristinava la normalità quotidiana, intrisa di fatica, dolore e ingiustizie sociali, ma anche di una potente religiosità che mal si accordava agli eccessi, al riso e alla festa.
Alcuni riti del carnevale si conservano ancora oggi; per citare due esempi: a Ronciglione si elegge ancora un re Carnevale, al quale vengono simbolicamente consegnate le chiavi della città e ad Ivrea si usa piantare in terra dei pali di legno detti “scarli”, che vengono poi bruciati la sera del martedì grasso a simboleggiare il momento in cui Carnevale cede il posto alla Quaresima.
Narni e la tradizione carnevalesca
Per quanto riguarda Narni, la tradizione carnevalesca è ormai completamente perduta: oggi il Carnevale è un momento di festa e di maschere riservato quasi esclusivamente ai bambini. Non sono certe le ragioni che hanno comportato la scomparsa del Carnevale nella nostra città, ma forse affondano le loro radici in un “Manuale per la diocesi e il clero narnese” conservato nel Palazzo Vescovile di Narni, che alcuni anni fa mi segnalò Claudio Magnosi, al quale vanno come sempre i miei ringraziamenti. Nel testo “Constitutiones et decreta diocesanae synodi ab illustrissimo et reverendissimo domino comite Raymundo Castello Dei. & Apostolicae sedis gratia episcopo Narniensi”, il vescovo Raimondo Castelli, sulla scia dei suoi predecessori, nel 1665 proibì di fatto i giochi popolari e i divertimenti (lotte, corse di cavalli, carnevale, teatro e balli), riconducendo la “festa” alla sola sfera religiosa. L’ordinanza fu accettata a Narni e in tutta la diocesi, con la sola eccezione di Otricoli che si ribellò rivolgendosi alla Camera apostolica.
Mariella Agri
BIBLIOGRAFIA
Allegri L., Teatro e spettacolo nel Medioevo, Laterza, 2011
Bachtin M., L’opera di Rabelais e la cultura popolare. Riso, carnevale e festa nella tradizione medievale e rinascimentale, Einaudi, 2001
Bartolucci R., Statuta illustrissimae Civitatis Narniae, Morphema, 2016
Toschi P., Le origini del teatro italiano, Boringhieri, 1976